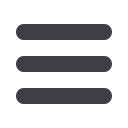
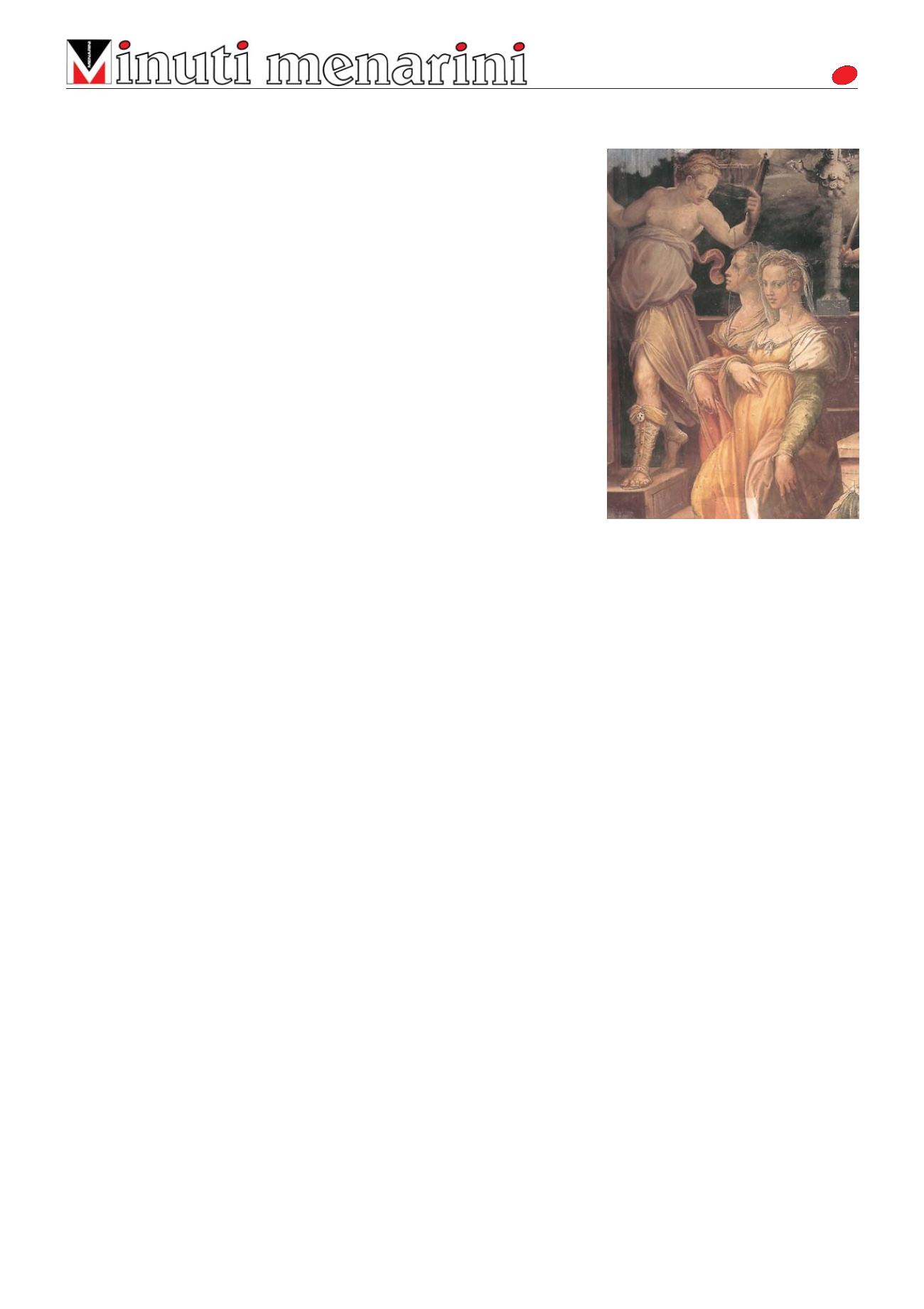
pag. 2
una serie di figure allego-
riche, Copia, Liberalità, Sa-
pienza, Prudenza, Fatica,
Onore e altre, sotto le quali
sono rappresentate storie
di pittori antichi. Vasari
fornisce una minuziosa de-
scrizione di alcuni fra gli
elementi più significativi
presenti nella decorazione
delle varie sale, con una an-
notazione sull’uso della
tempera, quasi abbando-
nato nella comune pratica
pittorica dell’epoca, e da
lui ripreso nella stesura di
alcune figure.
La cosiddetta
Camera della
Fama e delle Arti
fu com-
pletata più tardi: sulla volta
vi figurano «tutte le arti
che sono sotto il disegno,
o che da lui dependono» e
cioè Pittura, Scultura, Poe-
sia e Architettura; comple-
tavano la decorazione «otto
ovati per fare in essi otto
ritratti di naturale de’ primi
delle nostre arti»; sette de-
gli ovali furono riempiti,
presumibilmente in tempi
successivi, con le raffigu-
razioni dei massimi artisti
originari del territorio di
Arezzo: Spinello Aretino,
Bartolommeo della Gatta,
Michelangelo Buonarroti,
Andrea del Sarto, Lazzaro
Vasari, Luca Signorelli e,
immancabilmente, Gior-
gio Vasari stesso.
Gli affreschi per la casa
di Arezzo, che ospita oggi
il Museo e l’archivio Va-
sari, furono completati nel
corso del 1548 e rappre-
sentano un ciclo di dimen-
sioni notevoli, compren-
dendo una sala, due camere
e un corridoio. L’artista
aveva seguito personal-
mente anche la realizza-
zione architettonica della
propria dimora, la cui co-
struzione si era iniziata nel
1540, fino al completa-
mento della decorazione
pittorica, che costituisce
una sorta di “banco di
prova” per ben più impor-
tanti successive realizza-
zioni: infatti, la struttura
decorativa della
Sala del
Camino
verrà poi ripresa
dal Vasari nelle sale di Pa-
lazzo Vecchio a Firenze.
Un’impresa di dimensioni
molto più ridotte, ma par-
ticolarmente interessante
perché si tratta di un’opera
poco conosciuta e non ac-
cessibile al pubblico, è rap-
presentata dalla più tarda
decorazione di una sala nella
casa-studio fiorentina di
Vasari. Si tratta di un edi-
ficio che fu donato all’ar-
tista dal Granduca Cosimo
nel 1561, mentre Vasari
era impegnato già da cin-
que anni nel grande can-
tiere di Palazzo Vecchio,
dove gli era stata affidata
sia la realizzazione di un
nuovo salone per le ceri-
monie ufficiali, l’attuale
Salone dei Cinquecento
, sia
la ristrutturazione e deco-
razione in affresco di tre
quartieri, il
Quartiere degli
Eelementi
, il
Quartiere di
Leone X
, e il
Quartiere di Ee-
leonora
, per un totale di
quindici sale, oltre ad am-
bienti più piccoli e a una
cappella.
All’interno della sua abi-
tazione fiorentina l’artista
si limitò a dipingere una
sola stanza, la cosiddetta
Sala delle Arti e degli Arti-
sti
, nel corso del 1573,
quando ormai i lavori di
sistemazione e decorazione
di Palazzo Vecchio vol-
gevano al termine: le sto-
rie che vi sono illustrate -
incorniciate da fregi nei
quali sono rappresentate
le allegorie delle Arti, tre-
dici ritratti di artisti e uno
stemma mediceo con co-
rona granducale - rappre-
sentano episodi leggendari
nella vita di pittori dell’an-
tichità:
Apelle e il ciabattino
,
La scoperta della pittura e del
disegno
,
Lo studio del pittore,
e infine
Zeusi che dipinge le
cinque fanciulle di Agrigento
.
Secondo N. Lepri e A. Po-
lesati, autori della pubbli-
cazione di un ricco
corpus
di documenti relativi alla
vita di Vasari, nella casa
fiorentina nacque anche
nel 1567 il terzo ed ultimo
figlio dell’artista, frutto
della relazione con Isabella
Mora, nominata nei docu-
menti come “serva di casa”.
A questa nascita alludereb-
bero proprio alcuni par-
ticolari degli affreschi fio-
rentini, in cui Vasari sem-
bra aver voluto celebrare
questa tardiva paternità,
giunta nel suo sessantadue-
simo anno di età, e a venti
anni di distanza dalle na-
scita dei primi due figli.
Purtroppo, gli affreschi
versano in uno stato di pro-
gressivo degrado, al quale
sarebbe indispensabile porre
rimedio in tempi brevi per
non disperdere un docu-
mento interessante e inu-
suale nella parabola arti-
stica di Vasari: qui il carat-
tere delle scene raffigurate
appare infatti molto di-
verso da quello della deco-
razione della dimora are-
tina, in cui il tono domi-
nante era quello aulico e
celebrativo. Negli affre-
schi fiorentini le figure che
animano le scene rappre-
sentate vengono colte in
gesti di domestica quoti-
dianità, come nel riquadro
in cui le modelle si spo-
gliano nello studio di Zeusi,
mentre sullo sfondo gli al-
lievi si esercitano in uno
studiolo; allo stesso modo,
i paesaggi mostrano scorci
con edifici rustici e scene
di vita contadina, in una
dimensione assai lontana
dalle fastose ridondanze
delle opere ufficiali.
donata brugioni
Le modelle si recano nello studio di Zeusi - Firenze,
Casa Vasari, Sala delle Arti e degli Artisti









